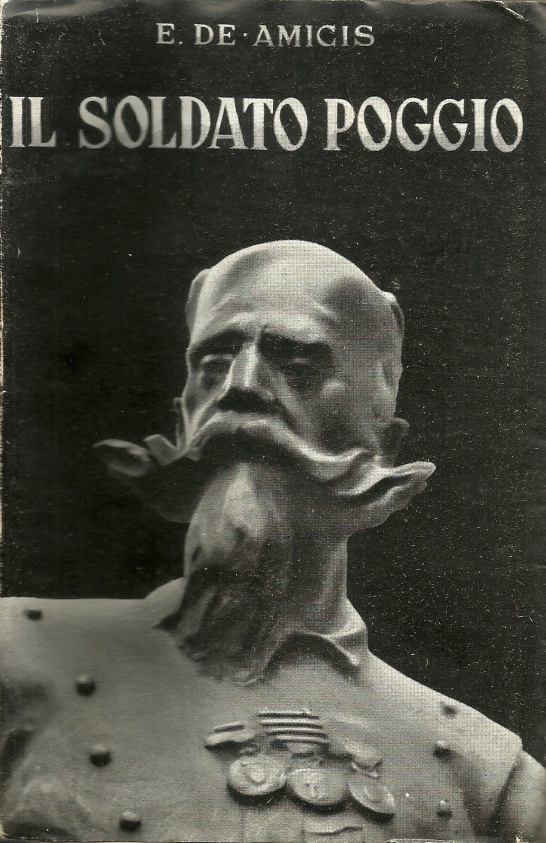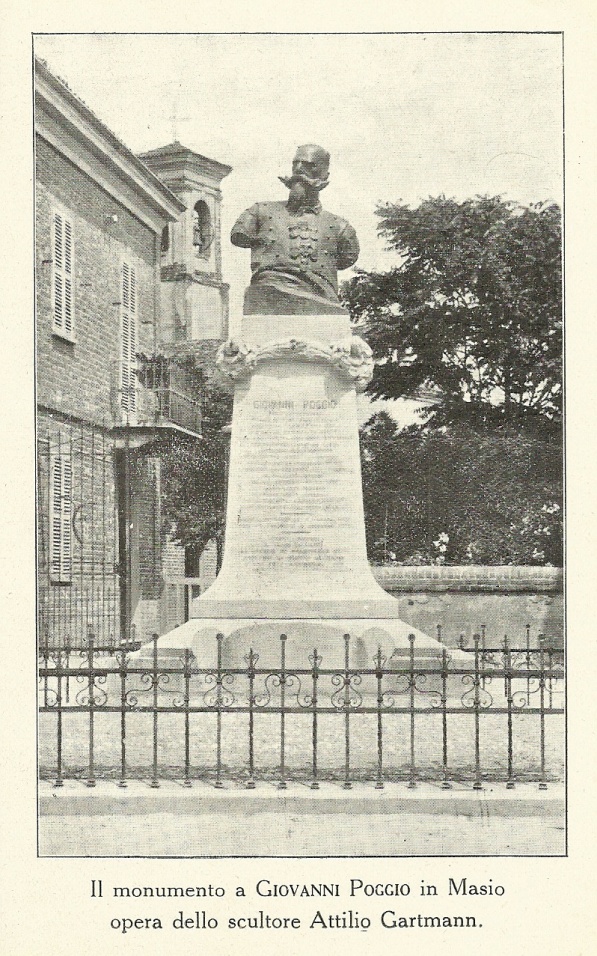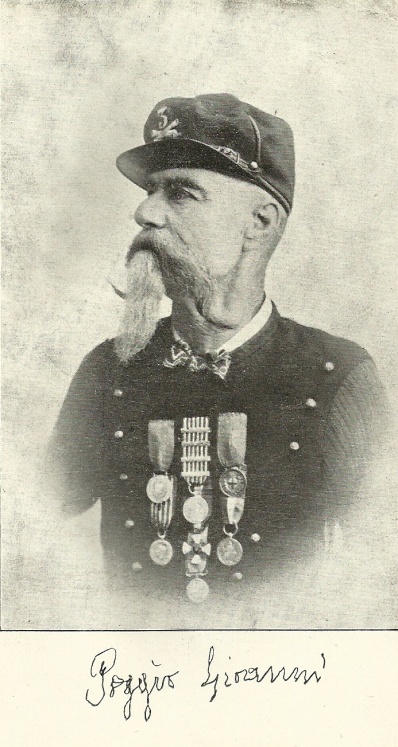È l’ultimo elegante appellativo “tecnico” affibbiato ai cittadini italiani dall’ultimo governo, ovvero dal nuovo Messia con i suoi apostoli e predicatori della sinistra italiana, oggi allargata per costituire l’amletico “partito unico”. Partito sostenuto con gran vigore dall’esercito dei dipendenti RAI con i suoi commentatori ben pagati ma scarsi di mestiere; da una pletora di pseudo giornalisti da scrivania; da troppi medici ospedalieri titolati “anticovid” più o meno ricattati dal governo e i vari ruffiani che pascolano servili e cerimoniosi nei vari settori dello sterminato apparato pubblico dello Stato.
A ben vedere è una nomea non del tutto errata a costatare il comportamento garrulo e ciarliero del gregge, mascherato a dovere da fantasiose mascherine (come dispone il decreto legge) e per nulla preoccupato del suo futuro, di quello dei giovani e del paese che li mantiene (ad oggi si calcola che circa il 68% degli italiani sono dipendenti a stipendio fisso nelle centinaia di strutture che lo Stato ha messo in piedi per motivi di voto politico).
E che dire delle centinaia di associazioni pseudo/umanitarie che giornalmente, in TV, chiedono denaro ai cittadini? Perché non aprire un’inchiesta per scoprire la destinazione di quel denaro?
Mi pregio di dilungarmi un tantino sul significato di “gregge”; chiedendo scusa ai dotti italianisti.
Nel dizionario Garzanti il sostantivo gregge è così definito: gruppo numeroso di pecore o altri ovini guidato, o custodito da un pastore; gran numero di persone adunate; in linguaggio religioso, da millenni sono i fedeli guidati spiritualmente dal clero; moltitudine di persone prive di iniziativa e di autonomia, pronte a ubbidire o approvare senza discutere; distinguersi dalla massa.
Nelle millenarie bibbie, il sostantivo gregge è correntemente usato dando interpretazioni a volte poco chiare. Nel vangelo di Giovanni è la pericope del buon Pastore.
Ce né per tutti i gusti, tuttavia chi ha proposto questo sostantivo dimostra poca dimestichezza con l’intelligenza, tantomeno nel mestiere ‘d savèj fé ‘n politica.
Tutto codesto scavare alla ricerca dell’etimo di una parola, da un senso o un significato di cosa realmente è il corpus di un popolo (nell’oggetto, italiani) nel pensiero politico dalla nostra illustre, ancorché abusiva, compagine di governo, il cui comportamento opera in toto fuori dalla condizione di gravità in un paese in perenne crisi e che s’illude essere in democrazia. Un pensiero che, supposto che nasca da un gruppo italiano d’individui pensanti e che sia tradotto da costoro in azioni politiche mirate a manovrare la produzione di vaccini, siringhe, ampolle, attrezzatura varia e pure l’andamento pilotato della pandemia a piacere nel tempo, con centinaia di migliaia di morti endemici; ebbene, credo che costoro meritino una pena perlomeno proporzionata alle loro responsabilità tuttora impunite.
Tutta l’estrema precisione matematica con cui, ora per ora, è stato reso pubblico alle TV il decorso del COVID sugli infetti ricoverati e sui morti, ha dell’incredibile, considerando il caotico disordine esistente da almeno un quarantennio nel settore sanitario, inoltre, non vi sono parametri di comparazione con il passato. Teniamo ben presente, ed è un fatto importante, che per il tempo precedente l’attuale epidemia, non esistono dati circa la situazione dei casi d’influenze e i loro decorsi più o meno gravi, tanto meno i casi mortali. Possiamo ipotizzare con una certa variabile, che quasi ogni famiglia abbia avuto almeno un membro influenzato curato dal medico di famiglia a casa propria. Onde per cui, il periodo che viviamo e moriamo è terrificante ma c’è un ma grande come un universo; a causa della disorganizzazione in cui la Sanità si è trovata ad affrontare; una situazione di estrema urgenza e gravità. Peggio ancora è che l’improbabile governo precedente e quello di quei giorni, abbia cavalcato con sinistra pervicacia la situazione, addossando al virus la gravissima crisi occupazionale già in atto da decenni in Italia, sulla quale c’è un silenzio a dir poco, reboante.
Ormai il nostro paese è in continuo stato di deliquio, ed è follia morire tragicamente per un cinico atto politico che produca fortune e denaro a miliardi per qualche finanziere pazzo, anche se siamo quasi giunti alla fine della festa.
L’autocrate che esercita il potere sul gregge a suon di decreti colorati, blocca di fatto tutto un paese che da troppi anni non lavora o lavora poco producendo quasi nulla. Pare che il virus, sia un prodotto da laboratorio, creato col proposito di scatenare un’epidemia, poi pandemia, chissà, forse per un tragico errore o sfuggito al controllo. Una situazione che inculca terrore e che uccide molto più dei fucili, in un sordido clima d’inganni e tradimenti, complice anche la chiesa guidata da un Papa, un piccolo prete comunista. Dire anarchia oggi è eufemistico, siamo oramai in un clima di latente rivolta. Tuttavia su quest’orrenda tragedia il dubbio permane, forte, ed è più che giustificato; mi si dia atto che queste ipotesi non sono affatto campate in aria.
L’Italia non produce più benessere da almeno un ventennio, causa governi incapaci di produrre trend positivi in ogni settore del mondo del lavoro, anzi, si è fatto tutto l’opposto e si costatano i pessimi risultati. E l’attuale governo ha rivendicato una tragica continuità rispetto ai precedenenti governi della sinistra che non hanno mosso dito per operare alla tutela di quel che rimane della fabbrica che produce seriamente lavoro.
Il Piemonte è stato un settore principe in economia dello sviluppo, dando benessere a tutta l’Italia.
Industrie, fabbriche, medie e piccole aziende, libere imprese, dove ancora operano sparuti gruppi di abili operai, tecnici, specialisti e artigiani trattati quale esecrabile manovalanza.
Tutto un mondo produttivo importante, che dipende in tutto e per tutto dalla manualità operaistica e artigianale creato con capacità e determinazione in due secoli e in soli pochi lustri portato volutamente dalla politica sulla via dell’estinzione in nome di un ipotetico settore dei servizi, quale il decantato “turismo” e la ristorazione, dove mestano rubicondi cuochi impegnati soprattutto a vendere casseruole e cucine personalizzate.
Dare a piene mani il denaro prestato, non serve a nulla, è una carità temporanea senza ricarica, che non ha futuro, poiché dopo queste generazioni non più giovani di lavoratori, di specialisti e artigiani, c’è il vuoto assoluto, quindi, nessuna cultura del lavoro da tramandare e soprattutto, nessuna certezza per il domani.
Nell’essere lavoratori nel settore artigianato, dobbiamo intendere l’artigiano moderno, ai giorni nostri visto come soggetto politico, poiché con l’industrializzazione qualcosa è cambiato; attrezzi, materiali, condizioni e sistemi di lavoro; è giusto seguire i tempi ma non il modo di essere, la passione nel lavorare, l’uso delle mani, che è il modo più antico, che si perde nella notte dei tempi per produrre “lavoro” come accezione. Penso sia utile un breve accenno di storia:
il termine artigiano deriva dal latino artifex, che è formato da due vocaboli: ars e fare, cioè fare arte. Lo stesso significato i greci intendevano con il termine demiourgos, che aggiunge qualcosa al significato complessivo; il termine greco si scompone in demos e ergon, ossia opera popolare. Quindi demiourgos significa colui che lavora per il pubblico, colui che esercita una professione per il pubblico. La radice di ars è il verbo aro che corrisponde al nostro arare, identico al greco aroo.
Poiché fin dagli albori della civiltà l’arare è stata una delle prime forme in cui l’uomo ha espresso il proprio intervento sulla natura, tale attività è passata, per uso metonimico, a indicare il lavoro in genere. Tale accezione è presente nel latino ars, che racchiude una varietà di significati: mestiere come professione ma anche come scienza, regole che precisano l’esercizio di un mestiere; attitudine a compiere una professione, con la conseguente acquisizione della “maestria”; infine, un modo di essere di chi è avvezzo alla pratica di un mestiere. L’arte non era un aspetto sopraggiunto ma era sentita come dote, anzi come indole propria, coltivando la quale, l’apprendista conseguiva un’abilità che lo portava a diventare maestro “master”. Per conseguire questo risultato, doveva passare attraverso una lunga pratica di esercizi, un apprendistato; era “iniziato”, edotto gradualmente sulle regole e i segreti del mestiere, che riceveva con la consegna di tacerli. L’artigiano che praticava un mestiere aveva la propria consegna, quasi un forziere da non aprire ma da cui trarre l’arte.
Artifex: fare arte servendosi del sapere e le mani erano lo strumento con cui modellavano e modellano tuttora l’opera, un mondo che sta scomparendo e la nuova Italia ne avrà ben donde.
Da un’indagine dell’Unione Artigiana-Confartigianato di Torino e Provincia.
Categorie iscritte albo imprese artigiani nel quinquennio 1995/2000.
| 01) Meccanica | 6.390 |
| 02) Auto moto cicli | 4.261 |
| 03) Galvanici | 298 |
| 04) Installatori | 7.345 |
| 05) Abbigliamento | 3.728 |
| 06) Tessitura | 251 |
| 07) Cuoio e calzature | 773 |
| 08) Orafi e orologiai | 503 |
| 09) Parrucchieri e affini | 5.081 |
| 10) Arti ausiliarie SANIT | 1.129 |
| 11) Legno | 2.545 |
| 12) Arredamento giardino | 899 |
| 13) Progettisti | 62 |
| 14) Vetro e ceramica | 389 |
| 15) Grafici | 1.411 |
| 16) Fotografi | 644 |
| 17) Strumenti musicali | 39 |
| 18) Trasporti | 6.731 |
| 19) Edili | 9.026 |
| 20) Pittori decoratori | 2.477 |
| 21) Materie plastiche | 403 |
| 22) Varie | 4.364 |
| 23) Chimici | 162 |
Il numero dei lavoranti artigiani fa parte dell’indagine ascritta soltanto per dare un’idea sulla consistenza degli occupati in quegli anni ma è esclusa dall’attuale ricerca, poiché essa si basa, nello specifico e in modo molto sintetico, sulle imprese artigiane ancora esistenti e sul grado di ammodernamento dei vari settori o categorie, per la rapida, enorme evoluzione tecnico-scientifica tuttora in corso.
Nel 2021 si calcola che si sia perso circa il 38% delle categorie indicate, causa la crisi politica incombente da troppi, troppi anni.
Partiamo dal sistema impiantistico idraulico, sanitario, termico ed elettrico nei nuovi edifici in costruzione nell’edilizia. Materiali, sistemi di lavorazione e attrezzatura idonea per una posa in opera corretta, tutto è completamente diverso da appena un quindicennio fa. Un meccanico d’auto, alzato un cofano motore, oggi si trova di fronte a problemi irrisolvibili per riparare un guasto, tanta è l’elettronica, non solo nel motore ma in tutta l’auto, per cui bisogna rinnovarsi e imparare l’uso di una nuova attrezzatura, ovvero: il computer.
A ben vedere, in pratica, sono fattori che coinvolgono quasi tutte la categorie artigiane, poiché il modernismo e la specializzazione corrono su binari paralleli. È un’ulteriore spinta, un invito per l’artigiano intelligente a coniugare la tradizione e l’arte dei “magister”, ovvero il “mestiere”, con il sapere scientifico.
Questo è l’intento ma sono solo parole al vento se non seminate su un terreno fertile nel quale crescere una robusta impalcatura che funga da nuovo, grande edificio in cui il “lavoro” e la “scuola” siano le basi future per questo povero paese dormiente che sarà, alla luce dei fatti, sempre più indebitato, povero e servo se non si sveglia. Da questo signor Draghi ci aspettiamo per le imprese il peggio del peggio. Costui e il suo governo sono orientati a trasformarci un paese turistico, che pensa con il ventre e tutto sommato, zuzzurellone; che bel futuro si sta approntando per l’italietta europea!
Una frase che si sente ripetere dai solerti commentatori RAI “Il presidente è al lavoro nella stesura dei nuovi decreti”; ovvero, le variabili colorate a pastello delle regioni italiane date dal caos esistente nelle percentuali numeriche dei contagiati. Andamento che ha uno sviluppo altalenante, calcolato in misura approssimativa dalla somministrazione del vaccino; milioni di ampolle di cui non sappiamo nulla sul contenuto e che va inoculata a tutti costi, poiché dev’essere consumata, in quanto deve crescere l’industria farmaceutica del vaccino “anticovid” e i vari componenti, quali; tamponi, siringhe, mascherine e tutto il corredo utile per eternare l’infezione, anche se oggi siamo passati al colore regionale giallo ma con milioni di volti cittadini “gialloverdi” dalla rabbia.
Il tradimento perpetrato alle votazioni del 2018, da parte del signor Mattarella e del PD, con la complicità della Merkel palesa i fatti. A costoro poco o nulla interessa la salute dei cittadini: somministrare a tutti il vaccino è ciò che conta nella cruda realtà; questi individui stanno preparando (ma è già pronta) una sorta di schedatura con un codice sui vaccinati, una sorta di provvedimento adottato a suo tempo dai nazisti nei confronti degli ebrei; siamo a questi livelli?
A questo punto anche Salvini e Berlusconi, alleati e ormai assoldati nel crogiolo del partito unico, riceveranno la loro paga, i trenta denari. Nei fatti l’opposizione è composta, forse dalla sola signora Meloni, donna decisa e siamo con lei ma stia attenta, sono molto potenti e s’inventeranno qualunque cosa per zittirla, è il loro subdolo metodo.
Intanto gli italiani stanno immobili a guardare, mentre la RAI trasmette, martellante, su tutte le reti, con una faccia tosta senza eguali, gli spot sulla favola dell’eccellenza italiana (i milioni di disoccupati?) e alla fine, vada come vada, festeggerà comunque in grande pompa nel prossimo Sanremo Festival le rovine del paese tra urla e parolacce, volgarizzando il bel canto e la buona musica.
Nel primo dopoguerra, finito precocemente il “miracolo economico italiano”, grazie soprattutto ai dollari del Piano Marshall ma anche dalla gran voglia di rinascita e ripresa degli italiani; ebbene, in circa un decennio gli effetti positivi cessarono, causa una sorta di folle guerra sindacale scatenata dai comunisti nelle grandi fabbriche (Brigate rosse e altri), che aveva coinvolto, nella cruda realtà, tutto il mondo del lavoro che, con fasi alterne nel corso dei decenni trascorsi, oggi volge verso un tragico epilogo, nonostante l’alibi del Covid.

Vittorio Ghidella
Immagine tratta da www.quattroruote.it
Vale la pena accennare sul come, nella brevità storica di qualche decennio, si sia potuto distruggere, nel senso più tragico del termine, un secolare sistema industriale piemontese costruito con fatica e sudore, da una cinica, criminale, classe politico-bancaria complice della sinistra italiana, in nome del solo profitto ad ogni costo. Una biblioteca non basterebbe per raccontare queste storie ma sono parole scritte nell’acqua; gli italiani e soprattutto i piemontesi se ne infischiano.
Il Piemonte, privato della sua egemonia industriale, è stato, suo malgrado, concausa di grave danno per il resto del paese, tuttavia ha delle responsabilità, anche se in parte giustificate dalla morte di alcuni importanti eredi di famiglie titolari di grandi industrie e di altri giovani rampanti, rivelatisi manager incapaci, colpevoli di irreparabili iniziative fallimentari.
Comunque è bene evidenziare, che il colpo ferale inferto a questi “gioielli” dell’industria piemontese in quel periodo dinamico e fiorente, sono stati uomini, che per circa un ventennio hanno fatto “terra bruciata” di importanti industrie che si erano sviluppate a livello mondiale.
Costoro, senza essere industriali d’esperienza ma finanzieri e banchieri, avevano messo le mani su queste industrie indebitate e bisognose di liquidità ma la visione dei professionisti della finanza sullo sviluppo di queste industrie era prettamente economico, ovvero; creare profitti riducendo drasticamente i costi materiali e umani che sono poi i dipendenti; in sostanza, spolparle, ridurle all’osso, per poi abbandonarle al loro destino.
Una visione allucinante, mancante di piani d’investimenti atti alla crescita e allo sviluppo, anzi, si panificava la chiusura di alcuni settori della progettazione, con licenziamenti e spostamenti di personale altamente specializzato in altri settori, persino in altri stabilimenti, con mansioni non di loro competenza, creando problemi insormontabili ai tecnici ma soprattutto nella produzione. In conclusione tutto aveva come obiettivo il profitto a qualunque costo.
Un sistema che può essere riassunto in una celebre frase: “meno auto più finanza”, detta da un principe dei banchieri; Cesare Romiti, l’uomo che fece quasi fallire la FIAT. In antitesi a l’ingegner Vittorio Ghidella, costui lo fece dimettere, poiché era un ostacolo alla sua carriera. L’ingegnere è stato il creatore della Uno, la Thema, la Y10, la Croma, la 164, tutte auto di grande successo per la FIAT. Alla fine il buon Romiti ha ricevuto, alla sua uscita dal gruppo, una gratificata “buona/uscita” di ben 105 miliardi di lire.
Ma il potente Cesare Romiti, o meglio la famiglia Romiti, aveva le mani in pasta anche in altre grandi aziende. Maurizio Romiti, figlio di Cesare, teneva i rapporti con Marco Rivetti, di Val Cervo, titolare dell’importante gruppo GFT (Gruppo Finanziario Tessile).

Spirito di gruppo. Gft, storie di moda e di costumi, ma soprattutto di persone
Edizioni Sottosopra
Gruppo GFT (Gruppo Finanziario Tessile).
Il gruppo, nel 1992, con i suoi 70 anni di vita e che comprendeva i marchi Facis, Marus e Cori, travolto dai debiti, era finito in una convulsa girandola di vari Istituti finanziari e banche. Marco Rivetti, malato, si era trovato al centro di una battaglia per il suo controllo tra Citibank e Gemina, la società guidata dall’onnipresente Cesare Romiti e di cui Mediobanca (di Enrico Cuccia), era socio di riferimento. Alla fine il controllo era passato a Gemina, la holding, che aveva acquistato la GFT nel settembre del 1993. Nel 1996 muore a 53 anni il presidente Marco Rivetti, nel 1997 Gemina trasferisce le attività industriali alla HDP (Holding di partecipazioni industriali) della famiglia Romiti.

La foto della sede del GFT in Borgata Aurora. Oggi ridotta a un reperto industriale
Immagine tratta da www.rottasutorino.it
Nel 2000 viene creata GFT Net (GFT international network), subholding di HDP, a cui viene trasferito anche il marchio Valentino. Sempre nel 2000, compra il marchio statunitense Joseph Abboud.
Nel febbraio 2003 la società chiude e vengono ceduti i marchi Facis e la collezione Valentino.
Fine della GFT e con essa i suoi dipendenti, le centinaia di laboratori artigiani e negozi dell’indotto sparsi in tutta Italia. Si noti che a questo grave problema occupazionale la famiglia Romiti proprio non era interessata.
Il “sistema” GFT era un modello particolare di lavoro compartecipe con il “padrone” Marco Rivetti sempre presente in azienda, come in una grande famiglia; una formula che ha funzionato bene nei diversi comparti della fabbrica sino all’ultimo giorno della sua esistenza.
L’immagine riprodotta è la copertina del libro di ben 349 pagine corredato da un numero imprecisato di fotografie che fissano, dalla nascita alla fine, la storia della GFT e il rapporto della famiglia Rivetti con i dipendenti.
Il titolo “SPIRITO DI GRUPPO” è significativo; queste poche parole sintetizzano in modo inequivocabile il corpo dell’azienda, che come un essere umano ha funzionato perfettamente in tutti i suoi organi interni e periferici. È opera dell’«Associazione Gruppo Anziani “Silvio Rivetti”, ex dipendenti GFT – ONLUS».
Un libro essenziale, che parla di “lavoro”, quello vero, non quello fatto di chiacchiere, inganni, truffe e debiti spaventosi, ovvero, il castello di carta sul quale è stata costruita la nuova Italia dissanguata, smembrata da voraci banchieri.
La FIAT e Cesare Romiti.
Un bancario, un finanziere attivissimo senza scrupoli, al pari di Enrico Cuccia e altri simili dei quali faccio seguito.
Romiti era compartecipe in decine di aziende, un personaggio ingombrante, un genio distruttore di gruppi industriali, che ha soltanto fatto soldi, nel nome del “non lavoro” e che ha ridotto la FIAT sull’orlo del fallimento. Un fatto che ha scandalizzato persino i tedeschi ma non gli italiani.
Sotto, l’immagine degli ex uffici direzionali della FIAT che dopo 115 anni lasciano Torino.
Tobias Piller ha scritto, nel non troppo lontano 22 febbraio 2014, sul Frankfurter Allgemeine un lungo articolo su questo accadimento incredibile, tutto italiano: ne riporto alcuni brani.
«La FIAT abbandona l’Italia ma questo non interessa quasi a nessuno. Cosa succederebbe invece negli Stati Uniti se la General Elettric trasferisse la sua sede in Olanda, o come reagirebbe la Gran Bretagna se Vodafone traslocasse a Zurigo, si chiede il piccolo giornale di intellettuali delle destra “Il Foglio”. L’approccio pragmatico degli anglosassoni condurrebbe a meditare su ciò che manca al loro Paese e quale fascino verso l’estero abbia subìto un Gruppo così grande, fino ad abbandonarlo. In un tale paese, senz’altro verrebbe subito promulgata una legge con il fine di trattenere Gruppi economici in patria, affinché desistano dal de localizzare. La decisione della FIAT rappresenta “uno schiaffo dell’economia globale all’interpretazione italiana della modernità”, recita il piccolo quotidiano, che viene finanziato tra l’altro anche da Silvio Berlusconi, che in economia politica non ha mai avuto la sufficienza».

Nella foto, il sorriso accattivante del banchiere Cesare Romiti
Immagine tratta da www.avvenire.it
«Il dibattito politico italiano ritorna subito ad occuparsi della faccende minuscole, di cui si compone la politica a Roma. Il giorno prima della comunicazione ufficiale circa la decisione di trasferire la sede legale del Gruppo, dopo la fusione con la Chrysler, in Olanda e la sede amministrativa in Gran Bretagna, il presidente della FIAT, John Elkann, insieme al suo amministratore delegato Sergio Marchionne, hanno reso visita al Presidente del Consiglio dei Ministri, per aggiornarlo in termini informali dei futuri sviluppi. Elkann, l’erede degli Agnelli, si è fatto intervistare dal gazzettino di corte e con toni tranquillizzanti ha garantito personalmente: “Il mio ufficio rimarrà a Torino”. È infatti previsto di riattivare quelle fabbriche già smantellate in Italia e che Torino rimarrà la centrale europea. Il governo comunque non si muove.
I sindacati si lamentano come sempre della cassa integrazione a zero ore, ripetutamente applicata nelle quattro fabbriche della FIAT operanti in Italia; rammentano inoltre a Marchionne le sue promesse di effettuare investimenti, espresse nel lontano 2010 ma rimandate e causa della crisi economica e del comportamento non cooperativo da parte dei sindacati. Gli appelli al governo ricalcano schemi degli anni settanta e ottanta e si limitano a richiedere che la FIAT sia convocata ad una tavola rotonda. Intanto il governo presieduto da Enrico Letta non si è finora mosso.

Nell’immagine gli ex uffici direzionali della FIAT che dopo 115 anni lasciano Torino
Immagine tratta da www.automoto.it
Inconsueto è stato però il commento minaccioso delle Entrate e della Riscossione, Attilio Befera che annunciava di verificare attentamente tale operazione di trasferimento della sede legale in Olanda e fiscale in Gran Bretagna. E questo potrebbe significare grossi problemi per il Gruppo. Infatti, come in altri diversi casi analoghi, verrebbe chiesto alla FIAT di tassare l’intera plusvalenza accumulata nella vecchia sede di Torino, al momento del trasferimento, comprese le licenze che si sono formate nel tempo grazie a ricerche e sviluppo italiani e che ora vengono sfruttate all’estero per la costruzione e la vendita dei marchi e dei modelli creati in Italia».
L’occupazione nel territorio viene ridotta.
«Per diversi imprenditori e direttori di alto livello non era stato necessario osservare il destino orribile di Marchionne al fine di orientarsi adeguatamente. Le decisione sugli investimenti all’estero vengono infatti prese cautamente e in tutto silenzio. Numerose imprese evitano di indicare nei loro bilanci ufficiali, ovvero, nei prospetti pubblici lo sviluppo dell’occupazione nelle loro unità all’estero. Uno studio di questo quotidiano evidenzia invece che da anni le imprese più importanti quotate in borsa, si orientano verso l’estero e tendenzialmente riducono l’occupazione nelle loro aziende sul territorio italiano. Proprio la FIAT ha mantenuto costante la sua forza lavoro in Italia sulla carta, poiché i lavoratori in cassa integrazione vengono annoverati ufficialmente tra gli occupati. Pur nel breve periodo tra il 2008 e il 2012 si registra un incremento dell’occupazione all’estero e una diminuzione sul territorio italiano, in capo a numerose imprese. Ciò riguarda persino i gruppi industriali controllati dallo Stato, come ENI e ENEL. Anche gruppi privati di comprovato successo come la Luxottica e Pirelli hanno diminuito l’organico italiano ed assunto migliaia di lavoratori all’estero. Delle 35 imprese industriali quotate nell’indice standard FTSE mib e nell’indice della media impresa FTSE mib cap, 14 hanno ridotto il personale in Italia, solo sei hanno incrementato il loro organico. All’estero il numero dei dipendenti di 25 imprese è cresciuto. Nel totale, l’occupazione all’estero dell’imprenditoria italiana è aumentata di 80.000 unità».
Tuttavia l’articolo si chiude con un severo monito che nessuno ha mai preso in considerazione.
«Il Presidente della Confindustria mette in guardia di fronte al pericolo che senza una modifica di rotta, in Italia si allargherà la desertificazione industriale. Ma tali rituali senza alcun esito si ripetono da tempo in Italia».
E oggi siamo giunti alla desertificazione industriale, ovvero, l’avverarsi del severo monito che aveva paventato il Presidente della Confindustria di quel tempo.
L’OLIVETTI gestione Carlo De Benedetti.
Giuseppe Silmo (uno dei tanti quadri intermedi olivettiani, come si definisce egli stesso), un testimone diretto, quindi nella possibilità di dare un contributo sul vissuto in drammatica storia di quella che è stata una grande azienda. Ha scritto un bel libro: “Olivetti. Una storia breve”. Termina con l’ingresso di Carlo De Benedetti nella Olivetti.
Silmo risponde alla domanda frequente: Come è potuta fallire la Olivetti?
Anche Roberta Garruccio e Franco Novara sul loro libro “Uomini e lavoro alla Olivetti”, in sintesi, danno una loro risposta:
«Fu la nuova cultura d’impresa portata da De Benedetti a distruggere la cultura precedente: la competizione interna non ne faceva parte; la Olivetti subì quindi una sorta di mutazione genetica e proprio il mutare delle politiche del personale si rilevò causa della crisi dell’azienda più che conseguenza di questa».

La “vecchia” fabbrica Olivetti di Adriano
Immagine tratta da www.grey-panthers.it
Giuseppe Silmo spiega in un articolo, scritto tempo addietro, il disastro che ha condotto l’azienda Olivetti alla rovina totale che, detto in modo sintetico, è il sistema “meno prodotto e più finanza” adottato da Cesare Romiti alla FIAT; da Enrico Cuccia e soci alla GFT; da Colaninno e Tronchetti Provera alla SIP-TELECOM e altre centinaia d’aziende dell’indotto di piccola e media grandezza che contavano molte centinaia di dipendenti che, quasi nell’immediato, si sono trovati disoccupati.
«Da un lato, una gestione sempre più orientata unicamente al risultato finanziario, con il passaggio da una conduzione industriale mirata alla produzione e agli investimenti nella ricerca e sviluppo, alla loro progressiva diminuzione, favorendo sempre più l’acquisto anziché il fabbricare, riducendo così drasticamente il valore aggiunto dei prodotti. Dall’altro il passaggio da una forte integrazione aziendale, con un comune sentire e una forte identità di squadra vincente, all’esaltazione del risultato individuale, mirato a massimizzare quello generale, ma con risultati nefasti sulla conflittualità interna e sul risultato stesso a medio lungo termine.
Tuttavia se questi sono i motivi che costituiscono il filo conduttore della gestione De Benedetti ma anche quella del suo successore Roberto Colannino, con conseguenze sempre più evidenti e gravi sul tessuto aziendale, ci sono nella Olivetti di De Benedetti, alcuni punti nodali che ne hanno segnato la storia; prima in positivo e poi sempre più in negativo».
L;’avventura olivettiana per De Benedetti inizia nel 1978 in positivo e con l’apporto di denaro fresco avvia con coraggio dei progetti pronti da tempo ma non attuati per problemi di solvibilità.
È un periodo fecondo, nel 1983, De Benedetti stipula un accordo con la AT& T (ATT American Telephone and Telegraph), la più grande compagnia telefonica di quel tempo, trasformando la Olivetti il primo produttore di PC europeo e il terzo a livello mondiale grazie alla fornitura del PC M24.

La “nuova” fabbrica Olivetti Benedettiana
Immagine tratta da www.interris.it
Ma Carlo De Benedetti ha una visione molto ampia, che mira ben oltre la Olivetti. Sente di avere una visione imprenditoriale allargata, più Europea, consona alle sue capacità imprenditoriali, ed è preso da un frenetico eclettismo operativo, intraprendendo una serie di audaci operazioni finanziarie trascurando il suo management alla Olivetti.
Carlo De Benedetti

Carlo De Benedetti
Immagine tratta da www.ilpost.it
Nel 1988 tenta la scalata alla Société Générale de Belgique, un importante gruppo industriale belga ma viene fermato dall’opposizione locale e dal gruppo francese Suez. Utilizza le finanziarie di famiglia De Benedetti CIR e CERUS, tuttavia un profondo cambiamento di gestione modifica la struttura manageriale e i consolidati equilibri di squadra nei metodi di lavoro, inoltre la sua assenza in azienda negli anni 1987 / 88 segnano particolari difficoltà di mercato pesanti per l’impresa.
Così disse Roberta Garruccio, in una sua conferenza l’11 maggio 2007, sul libro da lei scritto con Franco Novara “Uomini e lavoro alla Olivetti”, nei locali di quella che fu la Nuova ICO: «Fu la nuova cultura d’impresa portata da De Benedetti a distruggere la cultura precedente: la competizione interna non ne faceva parte; la Olivetti subì quindi una sorta di mutazione genetica e proprio il mutare delle politiche del personale si rivelò causa della crisi dell’Azienda più che conseguenza di questa».
Che é lo stesso ragionamento fatto da Giuseppe Silmo in un suo articolo sulla Olivetti: «Da un lato una gestione sempre più orientata unicamente al risultato finanziario, con il passaggio da una conduzione industriale mirata alla produzione a egli investimenti nella ricerca e sviluppo, alla loro progressiva diminuzione; dall’altro il passaggio da una forte integrazione aziendale, con un comune sentire e una forte identità di quadra vincente, all’esaltazione del risultato individuale, mirato a massimizzare quello generale ma con risultati nefasti sulla conflittualità interna e sul risultato stesso a medio lungo termine».
Grosso modo questi sono i motivi di fondo che costituiscono il filo conduttore di tutta la gestione De Benedetti e del suo successore, par suo, Roberto Colaninno, con conseguenze sempre più gravi sull’apparato aziendale.
(Rivedremo il Colaninno, quale disastroso attore principale, nel losco affaire Telecom).
Nel frattempo, con un’abile manovra, la AT&T acquista la maggioranza delle azioni della Olivetti, in pratica diventano i proprietari ma per formalizzarne la vendita, si scatena una vera guerra del management Olivetti contro De Benedetti deciso a venderla. Ma non viene venduta; all’ultimo
istante il De Benedetti, già in volo per firmare l’accordo con la AT&T, clamorosamente rinuncia
alla vendita. Ed è la rottura definitiva con gli americani.

Roberto Colaninno
Immagine tratta da www.topmanagers.it
Nel 1988 De Benedetti lascia l’incarico di Amministratore Delegato. Il nuovo management concretizza un’idea da tempo in punta di penna e divide l’azienda in due unità separate.
L’idea prevede due nuove strutture: la Olivetti Office e la Olivetti System and Network, con l’intento che i due nuovi settori avrebbero definito e snellito in modo migliore le branchie di attività migliorando il mercato. La realizzazione del progetto, affrontata in modo semplicistico e per nulla avveduto, non aveva tenuto conto della struttura ben collaudata di un’azienda profondamente integrata che operava all’unisono con i dipendenti. Questa spaccatura improvvisa crea confusione nei ruoli del personale, contrasti e una conflittualità mai esistita prima in fabbrica, provocando inoltre disorganizzazione nei settori commerciali e costi altissimi per lo sdoppiamento delle strutture. Nel 1992 il Bilancio del Gruppo Olivetti è fortemente negativo.
Per ridurre i costi, in quegli anni si è adottato il metodo spiccio dei banchieri e finanzieri, ovvero, massicci licenziamenti del personale. Nel 1988 il personale è di 57.760 unità, nel 1992 è ridotto a 40.401 unità. Vengono richiesti altri massicci licenziamenti che provocano dimissioni di importanti dirigenti anziani.
Nel 1992 la situazione è insostenibile e si corre ai ripari procedendo alla riunificazione dei rami dell’azienda. Ma oramai la Olivetti è alle corde; nel 1996 si scopre la grave situazione dei conti e il settore bancario blocca i fidi, vengono alla luce falsi nei bilanci, si dimettono direttori e dirigenti, nel 1996 il titolo va a picco mentre la Procura d’Ivrea apre un’inchiesta.
Ancora Giuseppe Silmo: «De Benedetti dopo 18 anni lascia la presidenza all’avvocato Antonio Tesone. Manterrà quella onoraria ancora per qualche anno. Anche Caio si dimette e gli subentra Roberto Colaninno, fino ad allora a capo della Sogefi (Società del gruppo De Benedetti).
L’azienda viene nuovamente divisa, i nomi sono cambiati ma questa volta l’esito è diverso: l’OLSY (Olivetti Systems, parte dell’ex OS&N) è ceduta alla Wang, l’Olivetti Personal Computer è anch’essa ceduta, l’Elea pure, e l’Olivetti Lexikon (in cui sono confluite le attività della Olivetti Office) diventa dopo la cessione anche dell’Olivetti Syntesis, l’erede di quasi tutte le poche attività operative e industriali Olivetti rimaste»
Si è giunti alla pura speculazione affaristico finanziaria e nel 2012 si realizza la parte più triste: chiude definitivamente l’ultimo pezzo della fabbrica Olivetti.
La triste realtà italiana della FIAT, della Olivetti, della GFT, della Telecom e tante altre aziende è stata rappresentata e guidata da banchieri senza scrupoli che le hanno distrutte o fatte fuggire (come la FIAT). Oggi abbiamo il “migliore” di tutti questi che governa l’Italia tutta e ne abbiamo un assaggio costatando gli attuali accadimenti e le sue intenzioni nelle ultime dichiarazioni pubbliche. Stiamo in attesa del peggio, grazie ai partiti dell’opposizione, traditori confluiti nel paradossale “partito unico”. Abbiamo paura e la paura porta terribili presagi e cattivi pensieri.
Carlo Ellena
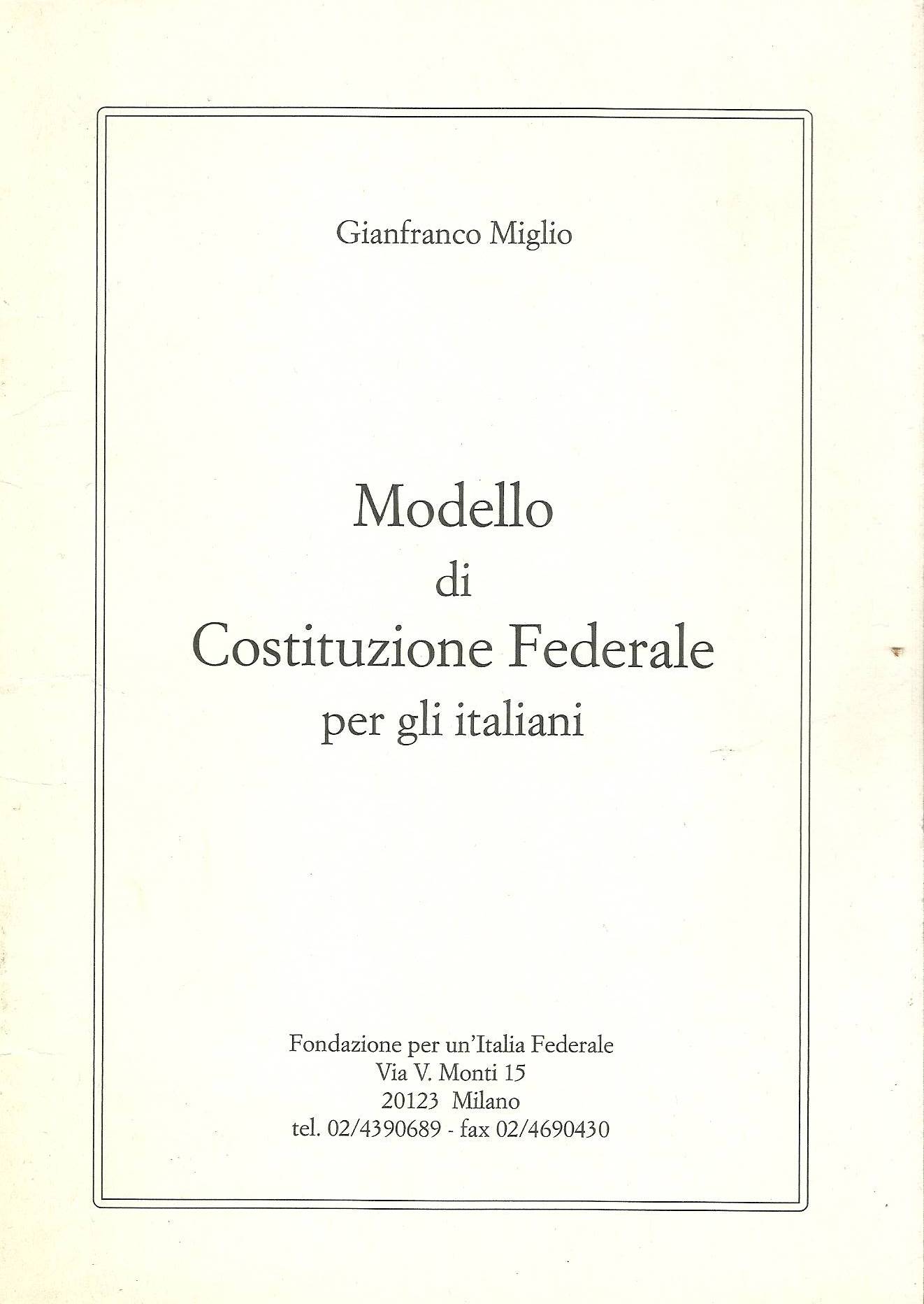




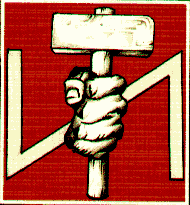


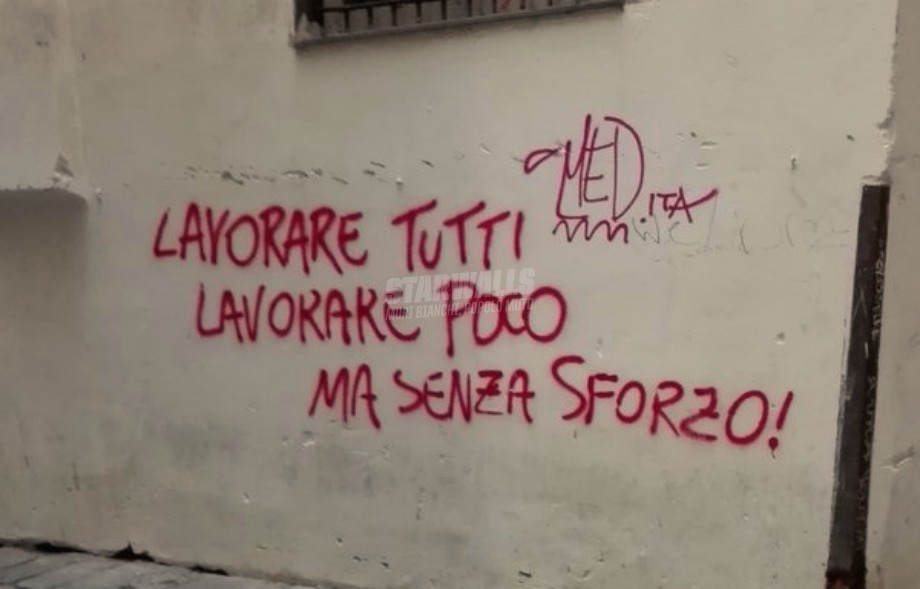

/https%3A//www.lastampa.it/image/contentid/policy%3A1.37779029%3A1571819384/cassa.jpg%3Ff%3Ddetail_558%26h%3D720%26w%3D1280%26%24p%24f%24h%24w%3Ded364f5)